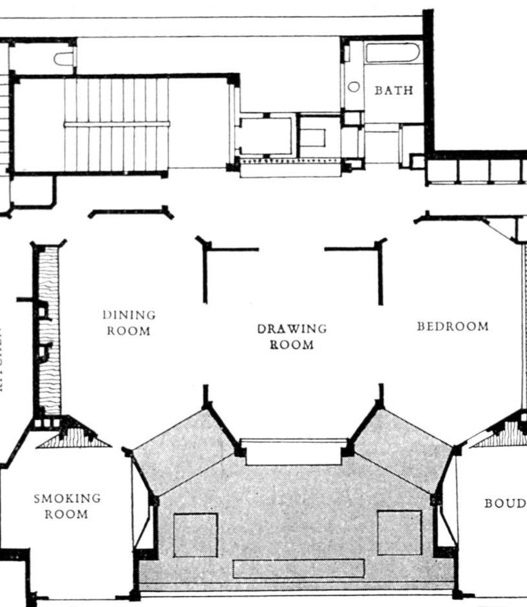La questione non è se l’architettura debba essere radicale o conservatrice, ma se sia onesta nei confronti del mondo che serve. Gli edifici influenzano il nostro consumo energetico, la nostra salute e il nostro senso di appartenenza. Oggi, il settore edile consuma circa un terzo dell’energia finale a livello mondiale, quindi ogni decisione relativa alla forma, alla facciata e alla planimetria riduce le emissioni o intrappola i rifiuti per decenni. Il cambiamento di cui abbiamo bisogno è pratico e umano: prima ridurre la domanda, progettare in base al clima e alla cultura locali, poi aggiungere tecnologie che siano davvero utili. Politiche come la Local Law 97 di New York City e l’Approved Document O del Regno Unito segnalano la fine dell’era del comfort garantito da involucri edilizi e gadget poco attenti.
Quello che occorre recuperare non è uno stile, ma un modo di pensare. Una progettazione attenta al clima, un’acustica accurata, una luce naturale non abbagliante e materiali piacevoli al tatto e all’uso. Le ricerche continuano a dimostrare che gli ambienti arricchiti dalla natura e dai materiali caldi riducono lo stress e favoriscono il benessere. Ciò significa che il concetto di “efficienza” non deve sostituire l'”esperienza umana”, ma coesistere con essa. Quando combiniamo strategie passive con le tecnologie giuste, otteniamo edifici più freschi d’estate, più silenziosi sul posto di lavoro e più rispettosi della rete elettrica.
Non si tratta di nostalgia. In tutto il mondo, gli architetti stanno riscoprendo le vecchie lezioni e le stanno combinando con nuovi strumenti. Nelle applicazioni tropicali e subtropicali, la temperatura viene controllata utilizzando ombreggiatura, ventilazione incrociata, massa e copertura vegetale, mentre nelle città vengono utilizzati vetri con motivi sicuri per gli uccelli per evitare collisioni senza ostacolare la luce del giorno. Il punto in comune di questi esempi è semplice: costruire in armonia con il clima, non contro di esso; proteggere la vita umana e non umana riducendo il fabbisogno energetico.
Tecniche da abbandonare: una valutazione critica
Dobbiamo abbandonare le abitudini che sembrano eleganti nei rendering ma che sono fallimentari dal punto di vista del ciclo di vita. Il test è molto semplice. Se una tecnica causa un maggiore funzionamento dei sistemi meccanici, ignora le condizioni climatiche locali, compromette la capacità delle persone di concentrarsi o riposare o provoca danni ecologici, allora quella tecnica deve essere abbandonata. I codici energetici e le norme sul surriscaldamento lo indicano ormai chiaramente, ma la ragione più profonda è di natura etica. Gli edifici sono permanenti, così come i loro difetti.
L’alternativa non è un’unica estetica, ma una mentalità performativa basata sulle persone e sullo spazio. Prima di valutare le attrezzature, valutate la facciata dell’edificio. Non aggiungete l’acustica in un secondo momento, ma includetela nel progetto. Scegliete i vetri non per un effetto cinematografico, ma per il panorama, la luce del giorno e il comfort. Prendete in considerazione le tradizioni locali come tettoie, cortili, persiane e muri spessi nella prima bozza. Questi non sono elementi che limitano la creatività. Sono condizioni che consentono agli edifici creativi di svolgere la loro funzione nel mondo reale.
Dipendenza eccessiva dalle facciate in vetro e spreco energetico
La torre interamente realizzata in vetro prometteva trasparenza e luce naturale, ma causava dispersione di calore in inverno, surriscaldamento in estate, riflessi sui tavoli e l’utilizzo di grandi impianti di climatizzazione per ovviare a tutti questi problemi. Le ricerche dimostrano chiaramente che la superficie vetrata, il valore U e il controllo del guadagno di calore solare sono elementi fondamentali per il risparmio energetico negli edifici in vetro. Più luce solare incontrollata entra, più energia si consuma per il raffreddamento e maggiore è la perdita di calore nei giorni freddi. Sebbene una buona illuminazione naturale sia preziosa, non è più una giustificazione per le pareti interamente in vetro.

Anche le normative non sono da meno. Il regolamento LL97 della città di New York limita le emissioni delle aziende, obbligando i proprietari di immobili ad adottare strategie di isolamento più rigorose, spandrel opachi e facciate miste con ante, nonché l’uso di vetri intelligenti solo dove necessario. Il vetro dinamico, quando fa parte di un sistema di montaggio equilibrato, può aiutare a ridurre i picchi di carico e l’abbagliamento, preservando la vista e la luce, ma è solo uno strumento, non una panacea. Se combinato con ombreggiature esterne e rapporti finestra-parete ragionevoli, il risultato è un impianto più piccolo e bollette più basse, oltre che un maggiore comfort.
Minimalismo estremo e perdita di calore
Il minimalismo può rendere un ambiente più tranquillo, ma quando elimina la consistenza, la naturalezza e il calore dei materiali, rischia di renderlo emotivamente piatto. Le persone riposano meglio nei luoghi che percepiscono come vivi: il legno che ammorbidisce il suono e il tatto, la luce del giorno modulata da profondità e ombre e piccoli elementi naturali che trasmettono un senso di sicurezza invece che di sterilità. Ricerche controllate stabiliscono una connessione tra elementi biofilici e materiali naturali e la riduzione delle reazioni allo stress. Ciò dimostra che la parola “pulito” non deve necessariamente significare “freddo”.

Riportare il calore non significa creare disordine. Significa creare un contrasto intenzionale: superfici ruvide accanto a superfici lisce, superfici dure accanto a superfici morbide, colori freddi accanto a calde ringhiere in legno. Nelle case, nelle scuole e nelle cliniche, queste scelte spesso non sono costose come una parete in vetro e apportano maggiori benefici al corpo. Quando gli spazi trasmettono una sensazione di sostegno, le persone vi rimangono più a lungo, guariscono più rapidamente e hanno bisogno di meno supporto meccanico per sentirsi a proprio agio.
Architettura iconica: oltre la funzionalità, il feticismo
La ricerca della prossima “icona del momento” può distogliere le squadre dall’uso, dai costi e dal tempo. I dati relativi ai megaprogetti sono preoccupanti: i ritardi nei programmi e gli sforamenti di budget sono all’ordine del giorno e i rischi possono trasformare un oggetto di prestigio in una storia esemplare. Quando l’immagine passa in primo piano e la funzionalità passa in secondo piano, le comunità ereditano debiti e complessità, mentre gli utenti devono fare i conti con piani bizzarri e costi operativi elevati.
Un modello migliore parte dai risultati. Definisci cosa significa successo per le persone all’interno e all’esterno dell’edificio (circolazione fluida, buona acustica e illuminazione, superfici resistenti, bollette basse) e lascia che queste priorità determinino la forma. La maggior parte degli edifici più amati sono diventati iconici grazie alla loro funzionalità; il loro profilo era un sottoprodotto del design, non il suo scopo principale.
La follia dell’open space acusticamente non progettato
Gli open space promettevano una maggiore collaborazione, ma i dati dimostrano che potrebbe essere vero il contrario. Quando tutti possono vedere e sentire tutti, le persone cercano di concentrarsi indossando le cuffie e leggendo i messaggi. Una nota ricerca che ha monitorato le interazioni prima e dopo l’apertura degli uffici ha rilevato una diminuzione della comunicazione faccia a faccia e un aumento della comunicazione digitale. Questo è un segno che l’esposizione continua non significa necessariamente connessione.

I rischi sono maggiori nelle aree dedicate all’apprendimento. Gli studi condotti sulle aule open space hanno evidenziato livelli elevati di rumore e scarsa intelligibilità del parlato. Ciò causa distrazione e pone in una posizione di svantaggio i bambini che già hanno difficoltà a sentire in ambienti rumorosi. La soluzione non è abbandonare completamente l’apertura, ma creare un piano acustico: bordi, stanze silenziose, assorbimento del suono dal soffitto e disposizioni che separino i rumori dai suoni delicati. Come quando progettate l’illuminazione, collaborate alla creazione di un design che offra possibilità di controllo e scelta.
Uno stile globale unico che ignora il clima locale
Copiare e incollare un modello generale basato sul clima ha riempito le città calde di vetri a tenuta stagna e standard di comfort importati che richiedono raffreddamento 24 ore su 24. In luoghi come l’India, l’abbandono delle ombreggiature locali, dei cortili e dei rivestimenti delle facciate traspiranti ha reso le ondate di calore più intense negli interni e ha causato il collasso della rete elettrica. Lo stile si diffonde facilmente, ma le leggi della fisica no.

La soluzione è tornare alle conoscenze climatiche. Le norme vigenti nel Regno Unito in materia di surriscaldamento e gli studi condotti sul raffreddamento passivo nelle regioni tropicali e subtropicali indicano la necessità di tornare all’orientamento, all’ombreggiamento, alle vie di ventilazione e alla massa termica. Non si tratta di passi indietro, ma di responsabilità odierne. Se gli edifici vengono progettati tenendo conto del sole, del vento e della cultura locale, richiedono meno macchinari, rimangono confortevoli più a lungo e danno un senso di appartenenza.
Saggezza dimenticata: tecniche che meritano di essere riportate in auge
Un tempo gli edifici offrivano un ambiente sociale fresco, luminoso e non abbagliante, senza compressori, in cui gli estranei non erano costretti a stare vicini gli uni agli altri. Non era magia, ma il risultato di un’attenta geometria, di vie d’aria, ombra, massa e spazi condivisi. Rivisitare queste idee non significa rifiutare la tecnologia. Significa partire dalla fisica e dalle persone e ricorrere alla tecnologia solo quando gli elementi fondamentali non sono sufficienti. L’approccio al comfort adattivo alla base delle moderne linee guida sul surriscaldamento ci porta nella stessa direzione: consentire agli occupanti dell’edificio di interagire con il clima, progettare involucri edilizi che respirano e fungono da cuscinetto e riservare il raffreddamento intensivo ai rari giorni in cui è davvero necessario.
Quando ci ispiriamo ai climi che hanno portato alla creazione di cortili, torri eoliche, verande e muri spessi, troviamo strategie che riducono i carichi pesanti e rendono gli ambienti più adatti al corpo. Non si tratta di nostalgia estetica. Si tratta di un miglioramento delle prestazioni a vantaggio delle persone: temperature più stabili, luce più morbida, aria più pulita e bollette più basse, oltre a legami sociali silenziosi che si sviluppano in spazi comuni ben progettati. Le ricerche sui cortili, sui frangivento e sui modelli di edilizia collettiva dimostrano che l’applicazione di questi principi con strumenti contemporanei porta a vantaggi misurabili in termini di comfort, energia e armonia comunitaria.
Strategie di raffreddamento e ventilazione passivi
Un edificio che si raffredda da solo inizia con l’aria che sa dove andare. L’effetto camino aspira l’aria calda verso l’alto e verso l’esterno; la ventilazione incrociata aspira l’aria più fresca dal basso e espelle il calore. I tradizionali cattura-vento hanno perfezionato questo sistema con lunghi alberi che raccolgono il vento e garantiscono il flusso d’aria anche nei giorni senza vento. Ricerche recenti dimostrano che i cattura-vento ben proporzionati, soprattutto se utilizzati insieme alla ventilazione notturna e all’ombreggiamento, possono garantire un abbassamento significativo della temperatura e un elevato ricambio d’aria senza utilizzare energia elettrica. Si tratta di una lezione semplice che si può imparare dalla tecnologia moderna: prima disegnate le zone di pressione, determinate le dimensioni delle aperture per i possibili venti e fate in modo che i canali e i ventilatori siano elementi ausiliari e non di supporto.

Anche le applicazioni di progettazione stanno registrando progressi in termini di standard di comfort. I modelli adattabili riconoscono che le persone tollerano e addirittura preferiscono un intervallo di comfort più ampio quando possono aprire le finestre, sentire il flusso d’aria o regolare le persiane. Nelle stagioni calde, ciò amplia l’obiettivo e premia il raffreddamento passivo che limita il raggiungimento dei livelli massimi di temperatura interna prima che le macchine entrino in funzione. Considerate il controllo solare come prima linea di difesa, quindi aggiungete vie di ventilazione controllate per dissipare il calore durante la notte. Il risultato è un impianto più piccolo, con emissioni di carbonio inferiori e spazi che non sembrano chiusi, ma vivaci.
L’uso dei cortili per la luce, l’aria e la vita
I cortili sono i motori del microclima. Catturando le brezze, diffondendo l’aria calda verso l’alto e consentendo alla luce del giorno di entrare nelle stanze, bilanciano le temperature eccessive. Studi e ricerche sul campo condotti in diversi climi dimostrano che, quando le proporzioni e l’orientamento dei cortili sono adeguati allo spazio, è possibile migliorare la ventilazione naturale, l’illuminazione naturale e la stabilità termica. I piani poco profondi intorno agli spazi vuoti riducono la distanza che la luce del giorno deve percorrere; la vegetazione e l’acqua raffreddano ulteriormente l’aria attraverso l’evapotraspirazione. Forma antica, prestazioni moderne.

Ciò che rende funzionale un cortile oggi è l’attenzione ai dettagli. Le ali strette aumentano la ventilazione incrociata tra le facciate opposte; le alte aperture nei vani scala o nei pozzi di luce intensificano il flusso d’aria creato dalla forza di sollevamento; le piante decidue lasciano entrare la luce del sole in inverno e forniscono protezione in estate. Le recenti ricerche sui “cortili solari” nei periodi freddi dimostrano che i bordi in vetro, che durante il giorno lasciano entrare il calore e di notte si chiudono, riducono il fabbisogno di riscaldamento senza compromettere la vita sociale. Il cortile, andando oltre lo spazio vuoto di un blocco, diventa il polmone e il salotto dell’edificio.
Materiali di provenienza locale e forme locali
La scelta dei materiali è una strategia climatica. Le pareti pesanti in pietra locale o terra cruda immagazzinano il calore durante il giorno nelle zone aride e calde e lo rilasciano lentamente dopo il tramonto; gli elementi costruttivi in legno e fibra, invece, respirano e regolano l’umidità nelle zone temperate. Preferire materiali provenienti dalle vicinanze non è solo un gesto culturale, ma riduce anche le emissioni legate al trasporto ed è generalmente in linea con dettagli sviluppati nel corso dei secoli in base al clima locale. Le linee guida sull’impronta di carbonio raccomandano costantemente l’uso di materiali provenienti da fonti locali e riciclati come primi passi pratici, mentre database come ICE aiutano a misurare gli impatti nelle prime fasi della progettazione.

Trasferire le forme architettoniche locali nell’architettura contemporanea significa riprodurne le prestazioni piuttosto che copiarne l’aspetto. Schermature, griglie e sporgenze profonde diventano brise-soleil calibrati; muri spessi diventano nuclei ad alta massa combinati con ventilazione notturna; tetti inclinati o ventilati diventano barriere radianti a scarico multiplo. Queste applicazioni, combinate con un calcolo onesto delle emissioni di carbonio e una moderna tenuta all’aria, danno vita a involucri edilizi che offrono prestazioni consolidate e innovative. Il risultato è un edificio che appartiene alla sua strada, al suo clima e al suo secolo.
Proporzioni incentrate sull’uomo e decorazioni
Gli spazi vengono percepiti dal corpo prima ancora che dal cervello. Le ricerche condotte all’intersezione tra architettura e cognizione evidenziano il punto ideale di complessità organizzata: se troppo semplice, perdiamo interesse; se troppo caotico, ci stanchiamo. I materiali, i contorni, le ombre e i ritmi rendono gli spazi leggibili e piacevoli, mentre i riferimenti naturali riducono lo stress. I modelli di progettazione biofilica riassumono le prove che dimostrano come la visione della natura, i materiali naturali e i motivi legati ai sistemi viventi possano migliorare l’umore e le prestazioni cognitive. Ciò ci ricorda che il “benessere” coinvolge anche la mente.

Da questo punto di vista, la decorazione non è fine a se stessa, ma è un insieme di informazioni che ci aiutano a orientarci, a riposarci e a prenderci cura degli spazi. Una ringhiera che si riscalda al tatto, un fregio che cattura la polvere e il sole, una sporgenza che alle quattro del pomeriggio disegna una linea morbida… Sono piccoli indizi che rendono un edificio a misura d’uomo. Quando i progettisti ripristinano le misure e i disegni in modo equilibrato, la manutenzione rimane semplice e lo spazio acquisisce un valore affettivo che ne impedisce la trasformazione in discarica. Anche questa resistenza emotiva è una strategia di sostenibilità.
Aree comuni multifunzionali all’interno dei complessi residenziali
Le case non finiscono fuori dalla porta; si estendono fino alle soglie, dove i vicini diventano più che semplici rumori dietro le pareti. La maggior parte dei modelli abitativi più vivibili al mondo sono stati progettati appositamente per creare spazi comuni (passaggi ad arco, cortili, terrazze per stendere il bucato e salotti “intermedi”) che rendono possibili e sicuri gli incontri casuali. La secolare tradizione di edilizia popolare di Vienna dimostra come gli spazi interni semipubblici generosi e i cortili paesaggistici possano sostenere comunità stabili e allo stesso tempo alloggi a prezzi accessibili. Questo modello è stato documentato anche in studi accademici e giornalistici.

Nelle affollate città tropicali, il Consiglio per l’edilizia abitativa e lo sviluppo di Singapore ha sviluppato il “void deck”, uno spazio comune al piano terra sotto i condomini, utilizzato anche come area per la circolazione, il gioco e le attività. Ricerche e rapporti sul campo descrivono come queste piattaforme ombreggiate si adattino continuamente: una settimana matrimoni, la settimana successiva esercizi per anziani, nel frattempo biblioteche e giardini pop-up. La lezione di progettazione che se ne può trarre è universale. Se si fornisce uno spazio dignitoso per lo sviluppo della vita quotidiana nei luoghi già frequentati dalle persone, il capitale sociale cresce senza bisogno di uno scenario programmato. Se lo si trasferisce nelle nuove abitazioni, si crea una resilienza tangibile.
Lezioni di ambiente: progettare il futuro imparando dal passato
Prima dell’avvento dell’aria condizionata, gli edifici sopravvivevano lavorando in armonia con il clima invece che lottando contro di esso. Le lezioni più affidabili che si possono trarre da quel periodo non sono di natura stilistica, ma ambientale. L’orientamento degli edifici consentiva di filtrare i raggi solari prima che colpissero le finestre, le divisioni facilitavano la circolazione dell’aria, i tetti trasformavano la pioggia in una fonte di energia e le pesanti pareti delle zone aride riducevano la differenza di temperatura tra le giornate calde e le notti fresche. Le ricerche e le linee guida moderne ribadiscono questi principi fondamentali e forniscono numeri, simulazioni e codici per adattarli ai giorni nostri. Il futuro non è il rifiuto della tecnologia, ma una trasformazione che passa prima dalla fisica e poi dai sensori.
Massa termica e materiali del suolo nelle zone aride
Nei climi aridi, dove la differenza tra le temperature diurne e notturne è notevole, la massa è una macchina silenziosa. Le pareti in terra — mattoni crudi, terra compressa, blocchi di terra compressa — assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente dopo il tramonto, livellando la curva della temperatura interna. Le linee guida di progettazione governative e gli studi peer-reviewed identificano questa proprietà di tamponamento come il vantaggio fondamentale dei materiali ad alta capacità termica: questi materiali impediscono alle temperature interne di raggiungere il picco e ritardano il flusso di calore, mantenendo gli ambienti a una temperatura costante anche se il deserto cambia da mezzogiorno a mezzanotte.

Recentemente, la scienza dei materiali ha aggiunto sfumature anziché contraddizioni. Gli studi condotti sui mattoni stabilizzati e rinforzati con fibre riportano bassi valori di conducibilità termica e alti valori di calore specifico, ma allo stesso tempo ne evidenziano anche i limiti, principalmente nella gestione dell’umidità e nei dettagli delle fondamenta e delle aperture. In pratica, il successo della facciata esterna deriva dalla combinazione dell’ombreggiamento diurno della massa con la ventilazione notturna quando l’aria esterna si raffredda. Questa combinazione trasforma le spesse pareti di terra da un riferimento culturale a una strategia energetica misurabile per le regioni calde e aride.
Tetti inclinati e tecniche di raccolta dell’acqua piovana
Un tetto inclinato funge sia da filtro climatico che da area di raccolta dell’acqua. Ricerche idrologiche dimostrano che le superfici dei tetti inclinate e lisce consentono una raccolta dell’acqua piovana notevolmente superiore rispetto alle superfici piane e ruvide. Ciò è dovuto al fatto che il deflusso è più rapido e le perdite dovute all’accumulo sulla superficie sono inferiori. Le linee guida sul campo sono in linea con questa realtà fisica: una certa inclinazione favorisce il deflusso pulito, mentre la scelta del materiale (metallo o tegole porose) modifica il coefficiente di deflusso e quindi la dimensione dello stoccaggio.

Progettare l’intera catena (grondaia, tubo di scarico, primo flusso, serbatoio) garantisce l’integrità del sistema. Le linee guida WASH per gli aiuti umanitari indicano che i tetti a falda unica facilitano la raccolta dell’acqua grazie alla presenza di un’unica grondaia e che la capacità di stoccaggio deve essere determinata in modo da soddisfare il fabbisogno di alcuni mesi di stagione secca nelle regioni con precipitazioni stagionali. In pratica, questo ha più a che fare con la resilienza che con il romanticismo rustico: la pioggia diventa un servizio pubblico a livello di edificio che riduce la pressione sui sistemi municipali e garantisce la sicurezza idrica durante le interruzioni.
Ombreggiatura profonda e finestre con persiane tipiche dell’architettura tropicale
Nelle regioni tropicali, il sole è fonte sia di luce che di calore. Sporgenti profonde, verande e persiane con angoli corretti impediscono l’ingresso eccessivo della luce solare, consentendo al contempo di godere della vista e della luce diffusa del cielo. Le linee guida di progettazione contemporanea per le zone tropicali (da UN-Habitat a CIBSE) traducono questa saggezza locale in dimensioni: angoli di taglio minimi, ante verticali combinate contro il sole basso a est/ovest e, nei punti in cui le facciate si riscaldano, tende separate riducono il riverbero e diminuiscono la necessità di raffreddamento.
Le persiane vengono ora progettate senza bisogno di fare ipotesi. Gli studi parametrici ottimizzano la profondità e l’inclinazione delle ante, migliorando la luce naturale utile mentre controllano il calore e favoriscono la ventilazione naturale. Altri studi stanno testando strategie di persiane montate centralmente che ottimizzano l’intensità dell’uso energetico insieme alle misurazioni della luce solare. Il messaggio pratico è semplice: progettate le persiane e le sporgenze in base alla geometria solare della vostra latitudine, quindi lasciate che i pannelli mobili regolino il flusso d’aria, in modo che le stanze risultino sempre ventilate senza il funzionamento continuo del compressore.
Orientamento degli edifici in base al sole e al vento
L’orientamento è la misura energetica più economica che richiede una “configurazione”. Le tabelle climatiche bioclimatiche classiche e moderne condividono lo stesso punto di vista: orientare le facciate vetrate principali verso il sole più mite, rendere le facciate est-ovest compatte o ombreggiate e regolare le aperture in modo da catturare i venti dominanti proteggendo dalle tempeste. Le tabelle di Mahoney lo riassumono in semplici raccomandazioni in base al tipo di clima: piani lunghi in direzione est-ovest, aperture di medie dimensioni a nord/sud nelle zone calde e umide e vie di ventilazione incrociata progettate fin dalla prima bozza.
Recenti studi hanno aggiunto alcune sfumature specifiche ai dispositivi: i dispositivi orizzontali offrono risultati ottimali sui fronti nord/sud, dove il sole è più alto, mentre le alette verticali attenuano la luce proveniente dagli angoli bassi del sole al mattino e al pomeriggio sui fronti est e ovest. In altre parole, l’orientamento pre-seleziona la famiglia di ombreggiatura e determina quanto facilmente è possibile mantenere il calore all’esterno senza perdere la luce. Iniziate a creare la massa tenendo conto del movimento del sole e della rosa dei venti, quindi regolate tutto il resto di conseguenza.
Efficienza energetica con forme di sezione tradizionali
Le partizioni rendono il clima più comprensibile. I soffitti alti, le ventilazioni del tetto, i pozzi di luce e gli atri spostano l’aria calda verso l’alto e verso l’esterno, creando differenze di pressione che attirano l’aria più fresca dall’esterno attraverso le aperture inferiori ombreggiate. Lo studio delle prestazioni dell’atrio e della ventilazione naturale estiva mostra come il dimensionamento e il controllo delle aperture possano ridurre i carichi di raffreddamento dell’esauritore a spinta e come la geometria dell’atrio (lungo e stretto per il galleggiamento, ampio e incrociato per il vento) modifichi il regime di flusso dell’aria.
I lavori di ottimizzazione effettuati sui pozzi di luce e sui profili dei soffitti offrono un ulteriore vantaggio: piccole modifiche alla sezione dei pozzi, al rapporto di ingresso-uscita e alla forma dei soffitti possono aumentare sia la distribuzione della luce diurna che la velocità naturale dell’aria, riducendo il riverbero e migliorando l’efficienza della ventilazione notturna. Le case tropicali tradizionali lo facevano in modo intuitivo con alte aperture di ventilazione, tetti ventilati e gallerie profondamente ombreggiate. Studi di casi basati su misurazioni effettuate oggi documentano la stessa resistenza e dimostrano che una buona sezione trasversale è un dispositivo energetico nascosto nell’architettura.
Continuità culturale nel design: ciò a cui non dovremmo mai rinunciare
L’architettura non si limita a fornirci un riparo, ma trasmette anche i significati che una comunità desidera preservare. Quando le città dimenticano questo aspetto, gli edifici diventano oggetti silenziosi. I teorici della cultura definiscono i luoghi e gli elementi permanenti “luoghi della memoria”: si tratta di luoghi, oggetti e rituali che racchiudono il passato e l’identità comune di un gruppo. Un buon design rafforza questi legami, mentre un cattivo design li spezza. Se studiamo come le culture antiche preservavano il significato attraverso la geometria, le soglie, l’artigianato e le storie, otteniamo strumenti pratici per rendere comprensibili e amati gli edifici del futuro.
La continuità vive anche nelle mani delle persone. Le tradizioni sopravvivono non attraverso la copia delle forme, ma attraverso l’insegnamento delle abilità. Il riconoscimento delle tradizionali arti architettoniche giapponesi in legno come patrimonio culturale immateriale ne è un esempio vivente: la falegnameria, l’intonacatura, la verniciatura e la lavorazione dei tatami sono preservate nel loro insieme, in modo che templi e case possano essere restaurati nel corso dei secoli rimanendo fedeli all’originale. Il messaggio per le applicazioni contemporanee è semplice: valorizzate la tecnica non come un extra nostalgico, ma come un bene culturale.
Geometria sacra e simbolismo nella pianificazione urbana
In diverse culture, i progetti urbanistici riflettono la cosmologia. Il piano urbanistico ottocentesco di Jaipur segue un modello mandala nonagonale tratto dal Vastu Shastra e adattato al territorio e al commercio. I suoi viali ad angolo retto e le facciate armoniose hanno creato una capitale leggibile e simbolica, che ancora oggi funge da mercato. Si tratta di un duplice compito della geometria: organizzare la vita quotidiana e codificare una visione del mondo.

Anche il Sud-Est asiatico offre un altro esempio significativo. Ad Angkor, i fossati e le gallerie rappresentano gli oceani e le montagne della cosmologia indù; le opere idrauliche della città e le colline dei templi combinano la narrazione spirituale con l’ingegneria idrologica. Letta in questo modo, l’infrastruttura diventa uno spazio rituale e richiede chiarezza tecnica in termini di simbolismo, orientamento, approccio e confini.
Anche le pragmatiche griglie romane avevano un significato. Il punto di intersezione tra cardo e decumanus determinava l’assetto della città ed era solitamente in linea con le pratiche divinatorie legate ai rituali di fondazione, garantendo al foro un ruolo centrale nei movimenti e nelle cerimonie. Oggi, quando progettiamo strade e piazze, possiamo attribuire a questi assi un significato pubblico, invece di limitarci a garantire il flusso del traffico.
Soglie, zone di transizione e ingressi rituali
Le culture hanno da tempo utilizzato l’architettura per segnare i periodi di transizione, poiché le soglie aiutano le persone ad assimilare il cambiamento. L’antropologia definisce questo fenomeno “liminarità”; questo concetto, che indica la fase intermedia di un rituale di transizione, si riflette chiaramente in elementi architettonici come ingressi, atri, portici e cortili, che ci rallentano e ci preparano. Il design che mette in scena l’arrivo agisce come un rituale delicato: separa il rumore dal silenzio, il lavoro dal culto, il privato dal pubblico.
Alcuni tipi di soglie sono chiaramente sacri. Il torii nei templi shintoisti simboleggia il passaggio dalla vita quotidiana allo spazio sacro; attraversarlo è una sorta di piccolo rito di attenzione. Nelle chiese inglesi, il lychgate un tempo segnava il passaggio dal villaggio al suolo sacro; accoglieva i dolenti, per poi lasciarli nel cortile della chiesa. Questi elementi sono facilmente comprensibili perché si trovano esattamente nel punto in cui cambia l’identità.
Gli altri limiti riguardano gli spazi interni e il clima. L’engawa giapponese, la striscia intermedia sotto i profondi cornicioni, mescola gli spazi interni ed esterni, li arieggia, fornisce ombra e diventa parte integrante della vita sociale ai suoi margini. I musei e le case contemporanei hanno riportato in auge questo elemento come un cuscinetto umano che trasforma una facciata da semplice superficie da guardare a luogo in cui soggiornare.
Celebrazione dell’artigianato e dell’autenticità dei materiali
La “fedeltà ai materiali” ha un significato etico, perché stabilisce un legame tra il modo in cui gli oggetti sono realizzati, come vengono percepiti e quanto durano. Dalla difesa dei difetti artigianali di Ruskin alla filosofia dei laboratori Bauhaus, l’argomentazione era la stessa: lasciare che la natura del legno, della pietra, dell’argilla e del metallo determinasse la forma e i dettagli; rendere leggibili i punti di connessione; conferire dignità alla lavorazione. Gli edifici che rispettano questo principio tendono a durare più a lungo e necessitano di manutenzione piuttosto che di ristrutturazione.
L’artigianato rende anche la cultura riparabile. Le competenze giapponesi nella conservazione dell’architettura in legno, inserite nella lista dell’UNESCO, dimostrano come una rete professionale sia in grado di preservare non solo i monumenti, ma un intero metodo di costruzione. Questa rete armonizza i tipi di legno, i lavori di falegnameria, i rivestimenti e i cicli di manutenzione, affinché gli edifici possano essere rinnovati senza perdere la loro anima. Considerare la manodopera qualificata come un patrimonio cambia anche il processo di approvvigionamento: non si ordina solo un prodotto, ma anche la conoscenza.
L’architettura come narrazione: dare significato
Le città raccontano storie non solo con lo stile, ma anche con la loro struttura. Kevin Lynch ha dimostrato che le persone si orientano grazie a strade ben definite, confini, zone, nodi e strutture simboliche. Quando questi elementi sono comprensibili, la città crea nella mente una mappa narrativa comune. Pertanto, progettare per la “visibilità” è un atto culturale: aiuta gli abitanti a ricordare e trasmettere la storia di un luogo.
I monumenti e gli edifici quotidiani possono fungere da “opere urbane” che custodiscono la memoria collettiva. Aldo Rossi ha sostenuto che strutture durevoli come teatri, cimiteri e mercati fissano l’identità di una città nel tempo, anche se il loro utilizzo cambia. I monumenti contemporanei raffinano ulteriormente questo linguaggio: nel Memoriale dell’11 settembre, gli spazi vuoti e le “vicinanze significative” dei nomi creano uno scenario che i visitatori leggono con i propri piedi, raccontando la perdita e la connessione.

Elementi architettonici legati alla memoria collettiva
La memoria è spesso racchiusa in piccole cose che si ripetono. Gli Stolpersteine europei — pietre di ottone fatte a mano posizionate sui marciapiedi davanti alle case selezionate — trasformano i percorsi quotidiani in atti commemorativi. Essendo decentralizzati e numerosi, trasferiscono la memoria dai musei alle strade e collegano silenziosamente le soglie delle porte private alla storia pubblica.
Le soglie e i cancelli elencati mostrano come le comunità abbiano letteralmente preservato il significato dei confini. I lychgate inglesi sono stati identificati per il loro ruolo storico e sociale nel preservare l’esperienza di ingresso nei terreni sacri. Considerare questi elementi non come oggetti decorativi, ma come infrastrutture urbane, rende i quartieri comprensibili attraverso le generazioni e assegna ai progettisti un compito: costruire nuovi passaggi che meritino di essere preservati.
Progettare con continuità culturale non è nostalgia, ma fedeltà alla coerenza. Le geometrie sacre armonizzano scopo e progetto. Le soglie mettono in scena le emozioni e l’ambiente. L’artigianato rende gli edifici accoglienti e riparabili. Le storie e i piccoli dettagli trasportano i ricordi nel tempo. Tutti insieme conferiscono alla moderna architettura la profondità che le manca e contribuiscono a far sentire le città del futuro come una casa.
Verso il futuro: ricostruire lo spirito dell’architettura
Se il secolo scorso ci ha insegnato a costruire velocemente, il prossimo secolo dovrebbe insegnarci a costruire in modo intelligente. Questo significa rivitalizzare l’educazione al design con conoscenze locali, fare in modo che la gente possa leggere la città come se fosse un libro e allineare le politiche affinché l’artigianato a basse emissioni di carbonio non sia una scelta di nicchia, ma l’opzione predefinita. Niente di tutto questo è nostalgico. Si tratta di un miglioramento: combinare pratiche collaudate nel tempo con la scienza e gli standard odierni per garantire che gli edifici diventino strutture solide, resistenti e amate. Il cambiamento è già iniziato nelle scuole, nelle città e nei ministeri, dai requisiti di alfabetizzazione climatica nella formazione professionale ai piani di ristrutturazione che premiano i lavori di ristrutturazione più profondi e puliti in tutto il continente.
Riqualificazione dei designer in materia di conoscenze locali
Il modo più rapido per costruire edifici migliori è cambiare ciò che insegniamo e da chi lo impariamo. Programmi basati sul know-how locale, come la Cattedra UNESCO di Architettura Terrosa gestita da CRAterre, trattano la terra, la calce, il legno e le fibre non come reperti museali, ma come tecnologie viventi con prestazioni misurabili. Questi programmi formano architetti e costruttori nell’esecuzione di prove sul terreno, nella progettazione che tiene conto dell’umidità e nella definizione dei dettagli per garantire la longevità, in modo che gli elementi costruttivi in terra e a base biologica soddisfino i moderni obiettivi di resistenza e sicurezza. L’Auroville Earth Institute diffonde questo approccio a livello globale attraverso corsi pratici e online sui blocchi di terra compressa e sulle volte a guscio sottile, dimostrando come i materiali locali possano soddisfare gli standard contemporanei in situazioni che richiedono una meticolosa attenzione ai dettagli e al controllo della qualità.
Anche le associazioni professionali stanno agendo in modo analogo. Il Royal Institute of British Architects richiede ora che l’alfabetizzazione climatica (considerazione del carbonio durante l’intero ciclo di vita, involucro edilizio che dia priorità ai materiali da costruzione e comfort adattabile) sia obbligatoria nella formazione accreditata e nella pratica continua. Indipendenti studi e commenti spingono le scuole a integrare profondamente queste competenze, invece di trattare la sostenibilità come materia facoltativa. Quando il programma di studi di base richiede agli studenti di realizzare modelli di carbonio, comprendere il valore della riparazione e cercare soluzioni adeguate al territorio, imparare dagli artigiani locali e dai climi non è più facoltativo, ma costituisce la base della progettazione.
Promuovere l’alfabetizzazione architettonica tra la popolazione
Una cultura in grado di “leggere” gli edifici richiede edifici migliori. I festival Open House trasformano intere città in aule per un fine settimana, offrendo a milioni di persone l’accesso diretto a luoghi normalmente chiusi al pubblico e alle storie che si celano dietro di essi. Solo nel 2023, la rete Open House Worldwide ha accolto oltre un milione di visitatori in migliaia di edifici, grazie all’impegno di migliaia di volontari: non si tratta di un pubblico di nicchia, ma di un’abitudine civica. I centri di architettura mantengono vivo questo interesse durante tutto l’anno: il Chicago Architecture Center raggiunge circa mezzo milione di persone all’anno attraverso mostre, gite sul fiume e programmi scolastici, mentre il Danish Architecture Center di Copenaghen organizza mostre e dibattiti che collegano il design alla vita quotidiana. Più le persone comprendono l’ambiente costruito, più richiedono la luce del giorno invece delle luci intense, l’uso misto invece della dispersione, la riparazione invece della demolizione.
Le città possono rafforzare questa alfabetizzazione non solo nei musei, ma anche nelle aule scolastiche. Le visite sul campo, i programmi di orientamento e gli studi per i giovani rendono comprensibili concetti come l’orientamento, l’ombreggiatura e la sezione trasversale in età in cui questi possono essere memorizzati. Quando un bambino di dieci anni impara perché un cortile è fresco o perché una sporgenza è importante, diventa un elettore e un cliente che si aspetta edifici migliori, completando così il ciclo tra cultura e applicazione.
Incentivi politici per tecniche tradizionali sostenibili
La politica è il luogo in cui le buone intenzioni diventano pratica comune. In Europa, la Ondata di Ristrutturazione è il fiore all’occhiello del Green Deal, che mira a raddoppiare i tassi di ristrutturazione annuali entro il 2030 e a modernizzare milioni di edifici con una guida e finanziamenti per interventi di ristrutturazione più profondi e più sostenibili. Il quadro RE2020 della Francia include un marchio statale “Bâtiment biosourcé” che premia la contabilità del carbonio durante l’intero ciclo di vita e, di conseguenza, l’uso di materiali bio-based come legno, paglia e canapa. Questo marchio è stato recentemente aggiornato per rafforzare i valori soglia e la governance. Questi strumenti consentono ai team di progettazione di identificare facilmente gli edifici regionali a basse emissioni di carbonio senza incontrare difficoltà.
Negli Stati Uniti, il riutilizzo adattabile e il miglioramento dell’involucro edilizio sono accelerati da tre strumenti: il Federal Historic Tax Credit, che dal 1976 ha portato a investimenti del settore privato per miliardi di dollari nella ristrutturazione di edifici storici; il finanziamento C-PACE, che consente ai proprietari di immobili di recuperare gli investimenti in efficienza energetica attraverso la valutazione immobiliare; e leggi municipali come la Local Law 97 di New York, che obbliga i proprietari immobiliari a ridurre significativamente le emissioni a partire dalla metà degli anni 2020, limitando le emissioni dei grandi edifici. Quando questi strumenti vengono combinati, soprattutto quando i materiali tradizionali e le misure passive aiutano a raggiungere gli obiettivi di prestazione, diventa più interessante preservare e migliorare un edificio piuttosto che ristrutturarlo.
Progetti di rianimazione di successo
A Bordeaux, Lacaton & Vassal, insieme a Frédéric Druot e Christophe Hutin, hanno dimostrato come fosse possibile trasformare gli alloggi sociali costruiti negli anni ’60 senza procedere allo sgombero o alla demolizione. Il progetto Grand Parc ha circondato tre torri con sottili giardini d’inverno e balconi, preservando la struttura originale e fornendo luce naturale, spazio e ventilazione a 530 appartamenti. Il risultato ha vinto il Premio Mies dell’UE 2019 e, cosa ancora più importante, ha dimostrato che amare ciò che esiste può essere superiore alla demolizione in termini di costi, emissioni di carbonio e dignità.

Nella regione del Sahel, il lavoro di Francis Kéré a Gando dimostra che è possibile costruire scuole fresche e resistenti con requisiti meccanici minimi, utilizzando argilla locale, manodopera comunitaria e ventilazione adeguata. La scuola elementare di Gando ha vinto il Premio Aga Khan e ha contribuito a lanciare un’iniziativa che unisce bellezza, adeguatezza climatica e artigianato. Lezioni simili emergono anche nella METI School di Anna Heringer in Bangladesh. Qui il bambù e la terra creano una struttura leggera e traspirante, costruita dagli studenti e dai contadini, che fornisce sia istruzione che educazione civica.

A livello di quartiere urbano, la zona Kampung Admiralty di Singapore sta riportando in auge l’idea delle terrazze comuni per le nuove generazioni, costruendo alloggi per anziani sopra cliniche, mercati e terrazze verdeggianti. La ventilazione naturale incrociata, la luce del giorno e gli spazi pubblici stratificati trasformano un’area compatta in un concentratore sociale, vincendo premi internazionali e offrendo un modello replicabile per le città che invecchiano. Nel frattempo, nella regione indiana di Kutch, la Fondazione Hunnarshala ha ricostruito migliaia di case dopo il terremoto del 2001, aggiornando le tecniche tradizionali come i bhunga circolari e i muri di terra stabilizzati con dettagli sismici. Questa è la prova che tradizione e sicurezza possono coesistere.

Design con sentimento, storia e responsabilità
Gli edifici influenzano i nostri corpi e i nostri ricordi. Il classico concetto di “visibilità” di Kevin Lynch ci ricorda che le città risultano leggibili e accoglienti quando strade, confini, zone, nodi e strutture simboliche sono facilmente comprensibili. Gli scritti di Aldo Rossi sulle strutture urbane spiegano perché alcuni tipi e luoghi mantengono la loro identità nel corso delle generazioni. Progettare tenendo conto di queste idee non significa copiare stili antichi, ma creare sequenze ed elementi che le persone possano ricordare, apprezzare e trasmettere.
Responsabilità significa anche proteggere silenziosamente la salute. Le prove alla base del design biofilico dimostrano che quando la natura viene integrata in modo sincero attraverso la luce del giorno, il panorama, i materiali e il microclima, lo stress diminuisce e le funzioni cognitive migliorano. Le linee guida sulla salute pubblica relative al rumore ambientale ricordano che la tranquillità non è un lusso, ma un’esigenza misurabile. Quando combiniamo questi fattori umani con involucri edilizi a basse emissioni di carbonio e artigianato locale, otteniamo spazi emotivamente generosi e tecnicamente efficienti: un futuro che ci fa sentire meglio perché funziona meglio.